Nel grande e polveroso archivio del cinema italiano, tra le pagine dimenticate dei B-movie e le pellicole scolorite di exploitation, brilla — o forse dovremmo dire lampeggia come un’insegna al neon difettosa — il nome di Bruno Mattei. Regista, montatore, sceneggiatore, produttore, e soprattutto alchimista della celluloide a basso costo, Mattei è stato uno degli ultimi cavalieri del cinema fatto “con poco e per tutti”. I suoi film, spesso considerati dei veri e propri “crimini contro la cinefilia”, sono in realtà piccoli miracoli di ingegno, furbizia e un amore disperato per il cinema in tutte le sue forme, anche (e soprattutto) le più becere.
Bruno Mattei non era solo Bruno Mattei. Era Vincent Dawn, Pierre Le Blanc, Michael Cardoso, Stefan Oblowsky, e una pletora di altri pseudonimi che servivano a confondere, incuriosire o semplicemente a mascherare il fatto che si trattasse sempre dello stesso infaticabile cineasta romano. Un trucco antico, quello degli pseudonimi, ma usato da Mattei con la maestria di un illusionista: servivano per spacciare i suoi film come produzioni americane, francesi o tedesche, aggirare limiti di distribuzione, o semplicemente dare un’aura di internazionalità a pellicole che a volte non uscivano nemmeno nei cinema del quartiere.
Il cinema di Bruno Mattei non si misura in qualità, ma in quantità. La sua arte non era quella della cesellatura, ma della produzione seriale, forsennata, quasi industriale. Il suo motto implicito era: “Meglio fare dieci film mediocri che uno solo decente”. Ed è proprio questa prolificità a renderlo un unicum: mentre altri registi si arrovellavano su inquadrature e sottotesti, lui lavorava come una macchina da guerra, a volte completando film in poche settimane, con budget risicati e troupe ridotte all’osso.
Ogni genere era terreno fertile per Mattei: horror cannibalico, zombie movie, war movie, erotico softcore, nazisploitation, fantascienza di terza mano, e persino porno soft spacciati per thriller psicologici. Non c’era limite alla sua creatività e al suo coraggio produttivo. Se c’era un filone che funzionava all’estero, Mattei lo imitava — anzi, lo clonava senza vergogna.
Chi ha detto che copiare è sempre sbagliato? Bruno Mattei aveva elevato il concetto del plagiarismo a forma d’arte. C’è una bellezza rozza e irresistibile nel modo in cui scippava sequenze da film famosi — Terminator 2, Aliens, Apocalypse Now, persino La sottile linea rossa — per inserirle senza troppi complimenti nei suoi film, spesso senza neppure badare alla coerenza cromatica o stilistica. Perché nel mondo di Mattei, la coerenza era un optional.
Tra le opere più celebri (e tristemente geniali) di Bruno Mattei spicca senza dubbio Virus – L’inferno dei morti viventi, conosciuto all’estero come Hell of the Living Dead. Questo film è un compendio perfetto di tutto ciò che rende il cinema di Mattei irresistibile: una trama derivativa, attori improbabili, dialoghi da incubo e un uso sfacciato di stock footage di documentari della National Geographic per simulare ambientazioni africane e sudamericane.
La storia? Un virus mortale sfugge da un laboratorio segreto e trasforma la popolazione in zombie famelici. Il protagonista? Un gruppo di soldati sgangherati e una giornalista che, in una delle scene più bizzarre del film, si spoglia nel mezzo della giungla per “mimetizzarsi” con una tribù. Il tutto condito da una colonna sonora dei Goblin, riciclata da film precedenti, e un montaggio talmente scellerato da rasentare l’arte astratta.
Eppure, Virus non è solo un disastro: è un capolavoro di follia, un sogno febbrile in formato VHS. Un film che non avrebbe mai dovuto esistere e che proprio per questo merita di essere visto.
Il nuovo millennio sembrava aver dimenticato Bruno Mattei, eppure lui, come una creatura del suo stesso universo zombesco, riemerse inaspettatamente con Nella terra dei cannibali. Un film talmente improbabile che sembra sia uscito per caso, una reliquia d’altri tempi girata con due lire nelle Filippine, con attori locali, armi giocattolo, e un copione che sembra scritto tra una piña colada e un’interruzione di corrente.
Mattei, ormai avanti negli anni ma ancora affamato di immagini, decide di girare non uno, ma ben cinque film in pochi mesi, riutilizzando scenografie, attori e persino dialoghi da un film all’altro. Nella terra dei cannibali è parte di questo blocco, ed è un omaggio (o una parodia inconsapevole) ai cannibal movie italiani degli anni ’70, come quelli di Ruggero Deodato o Umberto Lenzi. Ma dove quei film erano grezzi ma provocatori, Mattei realizza un’opera talmente assurda e disarticolata da sembrare il frutto di un generatore automatico di trama: soldati americani, tribù assetate di sangue, torture improbabili e un finale che arriva troppo tardi, ma è accolto come una liberazione.
Il bello? Questo film, teoricamente inutile, è diventato una gemma cult tra gli appassionati del cinema brutto fatto con amore. C’è un sapore nostalgico, quasi infantile, in questa pellicola sgangherata: come un disegno fatto male ma colorato con entusiasmo.
Come Stanlio e Ollio del cinema trash, Bruno Mattei e Claudio Fragasso formavano una delle coppie più temibili (e prolifiche) del cinema italiano a basso costo. Fragasso, che avrebbe poi diretto l’indimenticabile Troll 2, lavorò con Mattei in numerosi progetti, contribuendo spesso con soggetti e sceneggiature. Insieme, davano vita a film che sembravano provenire da un universo parallelo dove il senso logico, la grammatica cinematografica e la verosimiglianza erano aboliti per decreto.
Con l’arrivo degli anni ’90 e poi 2000, Mattei non si fermò. Continuò imperterrito a sfornare film per il mercato dell’home video e per le TV locali, spesso in co-produzione con le Filippine. Titoli come Rats – Notte di terrore, Violenza in un carcere femminile e Shocking Dark sono diventati cult per chi ama il cinema so bad it’s good. La morte arrivò nel 2007, portandosi via un autore che nessuno aveva davvero capito in vita, ma che oggi viene celebrato come un’icona postuma del cinema outsider.
C’è qualcosa di profondamente romantico nella figura di Bruno Mattei. Forse per la sua ostinazione, forse per il coraggio con cui affrontava ogni produzione come se fosse un duello all’ultimo ciak. Era il Don Chisciotte del cinema di genere, che combatteva contro i mulini a vento della critica, della distribuzione e del buon senso. I suoi film non volevano cambiare il mondo, ma volevano far parte di quel mondo – anche se dalla porta di servizio.
Oggi, nelle notti insonni di cinefili e nostalgici, c’è sempre qualcuno che scova una sua VHS impolverata, la inserisce nel lettore e si lascia trasportare in un universo dove tutto è possibile, dove il talento è secondario rispetto all’inventiva, e dove ogni fotogramma è un atto d’amore disperato e folle per il cinema.
Bruno Mattei non era un regista. Era un genere.
Un genere che profuma di plastica bruciata, di nebbia artificiale, di sangue finto e di sogni veri.
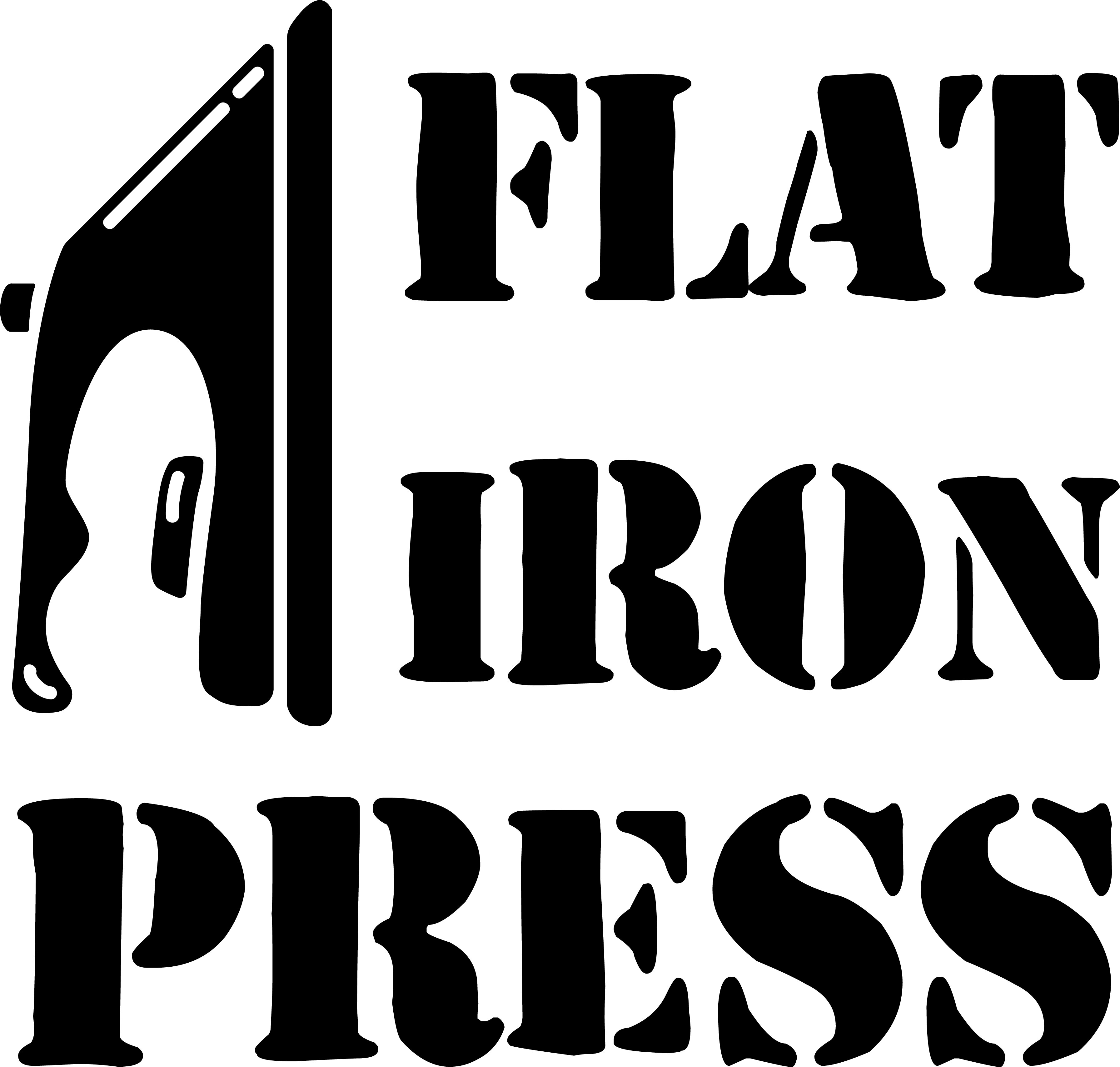
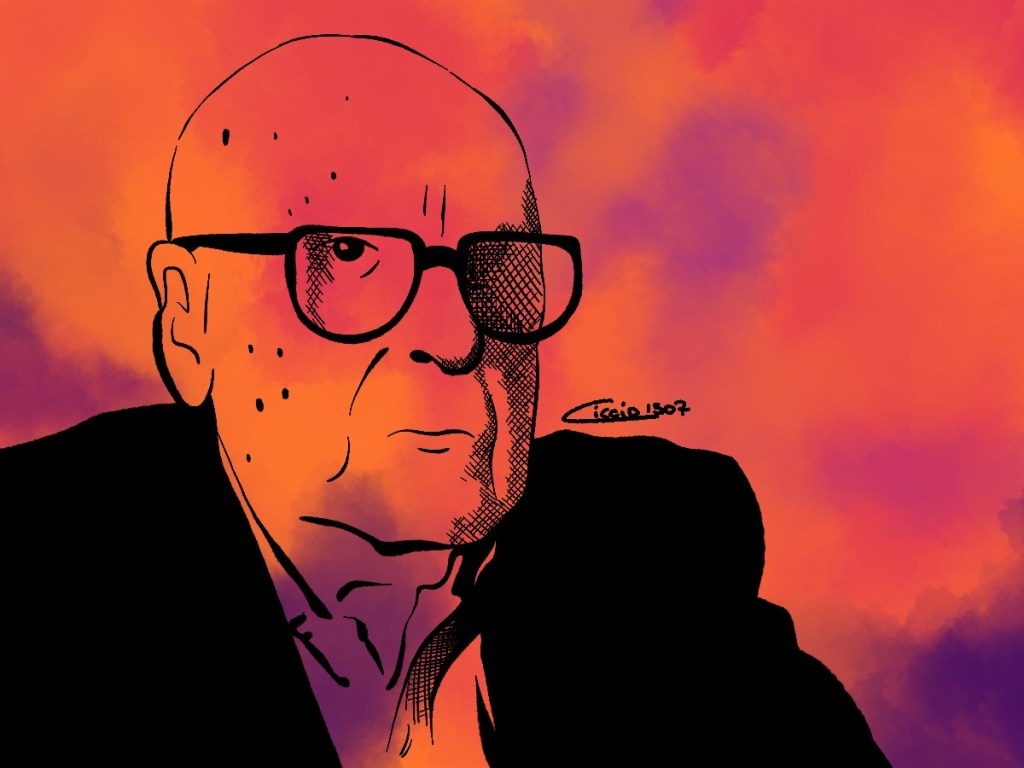




Lascia un commento